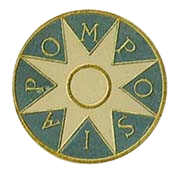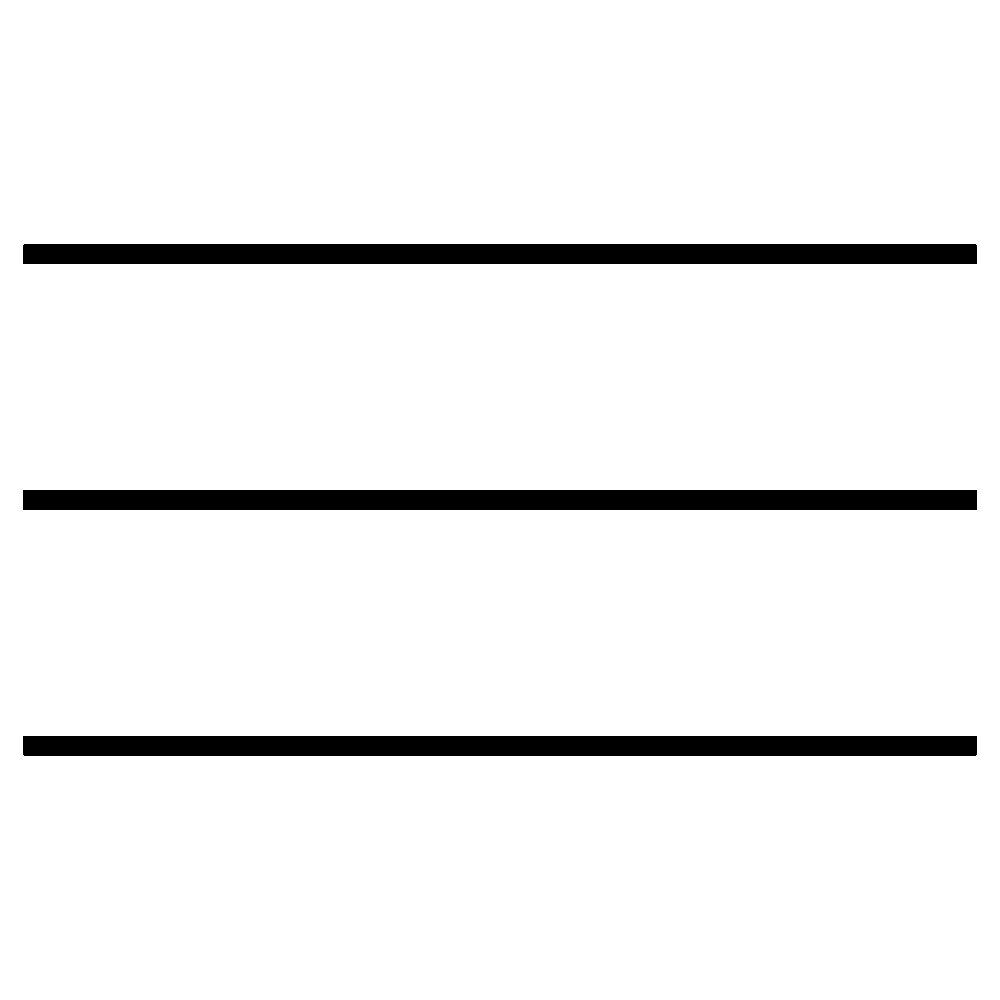Visita l’Abbazia
L’Abbazia di Pomposa è un antico monastero benedettino del IX secolo, celebre per la sua architettura romanica e per aver ospitato Guido d’Arezzo, inventore della notazione musicale moderna. Scopri affreschi e mosaici di profonda bellezza.

Informazioni turistiche
ABBAZIA DI POMPOSA E MUSEO POMPOSIANO
Via Pomposa Centro, 12 Codigoro (Fe)
tel: +39 0533 719119 (per info e biglietteria)
email: mn-bo.abbaziapo-fe@cultura.gov.it
ORARI DI APERTURA:
Dal Martedì alla Domenica dalle ore 8:30 alle 19:30
(chiusura biglietteria alle ore 18:45)
L’Abbazia di Pomposa sarà aperta anche durante i seguenti giorni: 25 Aprile, 28 Aprile, 1 Maggio, 4 Maggio, 2Giugno chiuso il 25 Dicembre.
GIORNATE AD INGRESSO GRATUITO:
La prima domenica di ogni mese l’ingresso è gratuito.
Anniversario della Liberazione 25 aprile, Riconsacrazione della chiesa di S. Maria 7 maggio, Festa della Repubblica 2 giugno, Giornata dell’Unità Nazionale 4 novembre e San Martino 11 novembre.
INGRESSO
Intero € 5,00 (nei giorni festivi € 3,00 e ingresso gratuito alla chiesa).
Intero con guida cartacea € 7,00.
Agevolato € 2,00 (nei giorni festivi ingresso gratuito alla Chiesa) giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni.
Gratuito per tutti i cittadini di età inferiore a 18 anni.
ACCESSIBILITÀ
Gli utenti con disabilità motoria possono accedere a tutte le sale del museo a piano terra attraverso l’ausilio di rampe.
Via Pomposa Centro, 12 Codigoro (FE)
+39 0533 719119
mn-bo.abbaziapo-fe@cultura.gov.it
La storia dell’Abbazia
L’Abbazia di Pomposa, situata nel comune di Codigoro in provincia di Ferrara, è uno dei più importanti complessi monastici dell’Italia settentrionale. Le sue origini risalgono al VI-VII secolo, quando i monaci benedettini fondarono un insediamento sull’Insula Pomposiana, un’isola boscosa circondata da rami del fiume Po e protetta dal mare.
Nel IX secolo l’abbazia acquisì rilievo, come attestato da una lettera di papa Giovanni VIII del 874. Nel 981 passò sotto il monastero di San Salvatore a Pavia, e successivamente sotto la giurisdizione dell’arcidiocesi di Ravenna. Grazie a donazioni private, Pomposa visse un periodo di grande prosperità, culminato con la consacrazione ufficiale nel 1026 da parte dell’abate Guido.
Durante il Medioevo, l’abbazia fu un centro culturale e spirituale di primo piano. Qui il monaco Guido d’Arezzo ideò la moderna notazione musicale, introducendo il tetragramma e il nome delle note, rivoluzionando la musica sacra. Tra il 1040 e il 1042 vi soggiornò anche Pier Damiani, e si dice che Dante Alighieri abbia visitato il monastero.
Nel corso dei secoli, Pomposa accumulò ricchezze e proprietà, arrivando a controllare 49 chiese in 18 diocesi. Tuttavia, a partire dal XIV secolo iniziò un lento declino, causato da fattori ambientali come la malaria e l’impaludamento della zona, aggravati dalla rotta di Ficarolo del 1152.


Nel 1653 papa Innocenzo X soppresse il monastero, che venne acquistato nel 1802 dalla famiglia Guiccioli. Alla fine del XIX secolo passò allo Stato italiano. Nel 1965 papa Paolo VI concesse ai vescovi di Comacchio il titolo di abate di Pomposa, poi trasferito agli arcivescovi di Ferrara-Comacchio nel 1986.
La basilica di Santa Maria Assunta, cuore dell’abbazia, conserva un impianto romanico con tre navate divise da colonne romane e bizantine. Il pavimento in opus sectile, risalente dal VI al XII secolo, è decorato con motivi simbolici e figurativi. Le pareti sono affrescate con cicli del Trecento di scuola bolognese, raffiguranti scene dell’Antico e Nuovo Testamento, dell’Apocalisse e del Giudizio Universale.
Accanto alla basilica si trovano il campanile romanico-lombardo del 1063, alto 48 metri, il monastero con il chiostro, il refettorio e la sala capitolare, e il Palazzo della Ragione, dove gli abati amministravano la giustizia. Oggi il complesso ospita anche il Museo Pomposiano, che conserva reperti e opere d’arte provenienti dall’abbazia.

San Guido
Il personaggio principale nelle vicende dell’abbazia nella sua fase di maggiore splendore è l’abate Guido, vissuto tra X e XI secolo.
Originario del ravennate, dopo studi laici sentì il fascino della vita dedicata a Dio e a Roma approfondì gli studi ecclesiastici. Tornò poi nei luoghi a lui familiari avendo appreso della fama spirituale di un tale Martino, abate di Pomposa. Sotto la guida di Martino, Guido si avvicinò alla vita eremitica ma non rigettò mai il mondo cenobitico, accettando la nomina alla guida del monastero di Pomposa dal 1008. È al suo abbaziato che si deve ascrivere l’ampliamento dell’edificio di culto.
Intorno a Guido confluirono una serie di personaggi ben noti nel panorama culturale dell’epoca: Bonifacio di Canossa, padre di Matilde, così come il vescovo di Ravenna, Gebeardo di Eichstätt, furono due assidui frequentatori dell’abbazia: il primo volle essere fustigato a Pomposa per scontare i suoi peccati di simonia, il secondo venne dipinto nella sala del refettorio nel famoso miracolo della mutazione dell’acqua in vino.
Guido d’Arezzo invece vi impostò e sperimentò la sua pratica canora che rivoluzionò la didattica musicale occidentale. Fu monaco a Pomposa dal 1013 in avanti e qui elaborò un nuovo sistema di notazione ed esecuzione musicale, la solmisazione, che permetteva a chiunque di leggere ed eseguire a prima vista una melodia sconosciuta, velocizzando l’apprendimento e svincolandolo dalla trasmissione orale.
Arte in abbazia
La Chiesa di S. Maria di Pomposa presenta oggi una pianta basilicale a tre navate con abside poligonale, tipica dell’ambiente ravennate, così come di provenienza ravennate sono moltissimi elementi strutturali interni, dai capitelli ai mosaici pavimentali, che testimoniano la pratica tipicamente medievale del reimpiego, vale a dire il riutilizzo di materiali di pregio, più antichi, in nuove strutture.
Così come appare oggi l’interno della chiesa, completamente affrescato, è il risultato di un palinsesto composito formatosi nei secoli.
Sebbene la prevalenza sia data dagli affreschi trecenteschi dell’abside e della navata centrale, è possibile scorgere qua e là qualche testimonianza della decorazione dei secoli precedenti e leggere gli affreschi in senso cronologico, dal più antico al più recente.

Affreschi
La decorazione dell’abside, opera di Vitale da Bologna nel XIV secolo, raffigura un Cristo benedicente dentro la Mandorla Mistica con a destra la Vergine, seguita da uno stuolo di principesse, vergini, martiri e l’abate Andrea, committente dell’opera, in ginocchio, mentre a sinistra la figura di S. Michele Arcangelo è nell’atto di pesare le anime con la bilancia a due piatti.
Nella fascia centrale sono raffigurati San Giovanni Battista e San Martino tra evangelisti e dottori della Chiesa. Nel registro inferiore è illustrata la storia di S. Eustachio.
Ad un periodo successivo alla realizzazione dell’abside, ma sempre di scuola vitaliana, sono gli affreschi della navata centrale della chiesa, divisi in tre ordini. Le scene si leggono in senso orario procedendo dall’abside verso l’entrata della chiesa: nell’ordine superiore scene tratte dall’Antico Testamento mentre nell’ ordine mediano vi sono scene tratte dal Nuovo Testamento. L’ordine inferiore è destinato al ciclo dall’Apocalisse. La visita alla chiesa si conclude con il monito del Giudizio Universale, posto sulla controfacciata.
Mosaici
Una particolare attenzione merita il pavimento della navata centrale in mosaico e opus sectile. Si presenta come una complessa distesa, suddivisa in quattro settori databili tra XI e XII secolo, simile a quelle di molte chiese veneziane.
Il settore più antico è quello che si trova nella zona del presbiterio, realizzato attraverso una commistione delle due tecniche, tipica di ambienti bizantini.
Il secondo settore è costituito da un quinconce di grandi dimensioni con un cerchio al centro da cui si dipartono quattro bracci di una croce.
All’interno di questo grande pannello è inserita la piccola lastra marmorea che ricorda la dedicazione della chiesa il 7 maggio 1026.
A seguire, spostandosi verso l’ingresso, l’unico mosaico figurato di Pomposa. Oggetto di questo pannello musivo sono animali e forme medievali. Il mosaico figurato è posto in una zona originariamente destinata ai soli monaci, mentre il settore più vicino all’ingresso della Chiesa, posteriore di circa un secolo rispetto agli altri, è decorato con un quinconce di grandi dimensioni.

Architettura
Il complesso della chiesa, caratterizzato dall’atrio rettangolare con tre arcate d’ingresso e il noto campanile, sono l’immagine distintiva di Pomposa.
L’atrio non esisteva nelle più antiche fasi della chiesa: fu aggiunto, ampliandone la planimetria, nel 1026. Di tale opera fu autore il magister Mazulo.
Sullo sfondo di un paramento tipicamente medievale di mattoni irregolari e policromi, si dispongono con simmetria le due finestre a rosone chiuse da transenne traforate, cosi come pure gli altorilievi zoomorfi, alternati a bacini ceramici, disposti all’altezza degli archi d’accesso al portale.
La costruzione del campanile ebbe inizio invece nel 1063, ad opera del magister Deusdedit. Si tratta di un mirabile esempio di stile romanico: alto circa 48 m, l’interno è articolato in nove piani percorribili fino a quello delle campane attraverso 201 gradini. Il progressivo ampliamento delle aperture da monofore a luce crescente, a bifore, trifore e quadrifore man mano che l’altezza aumenta, oltre che essere un espediente per l’alleggerimento strutturale, serve ad esaltare il senso di ascensione dello spirito verso l’alto.